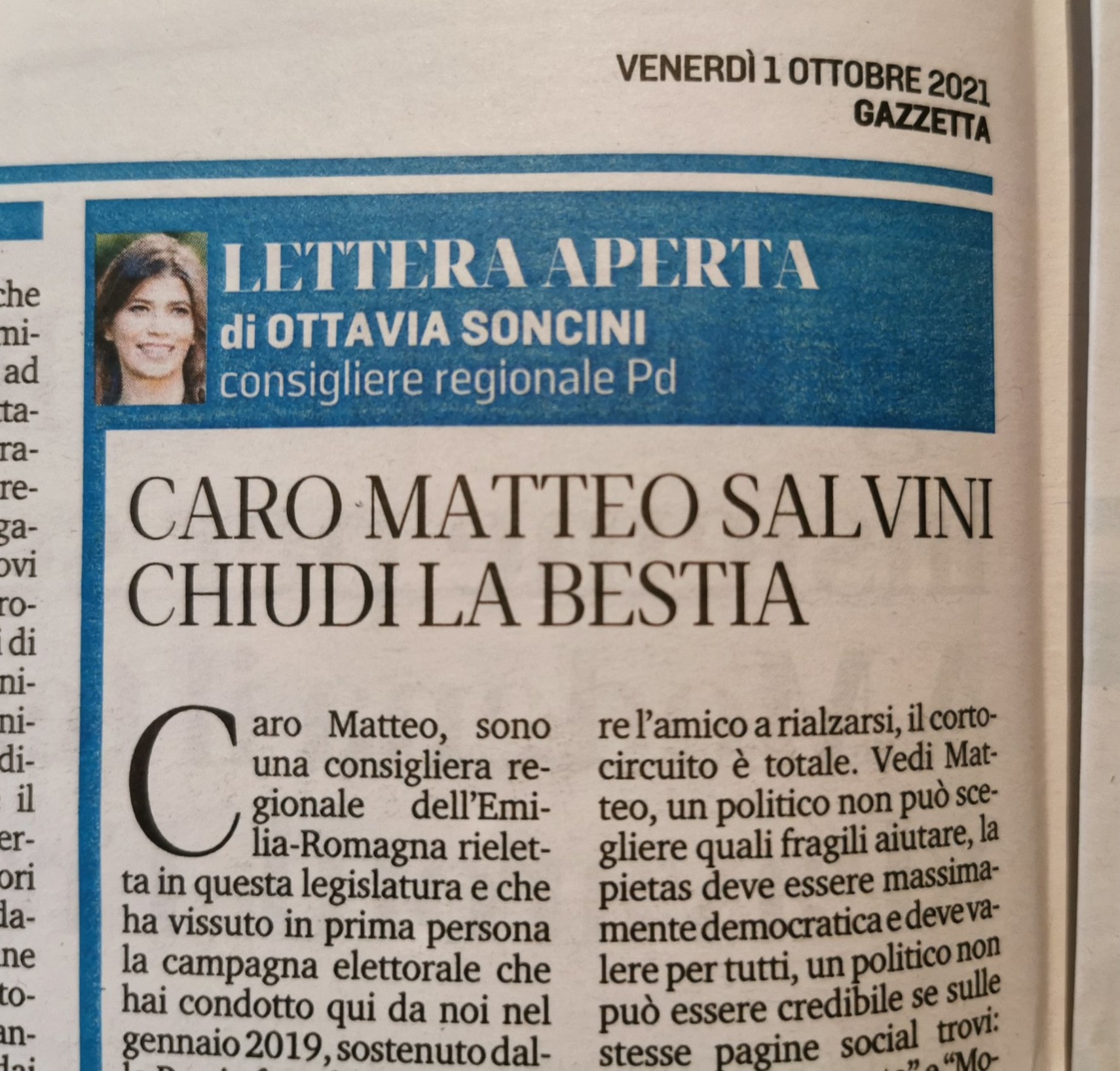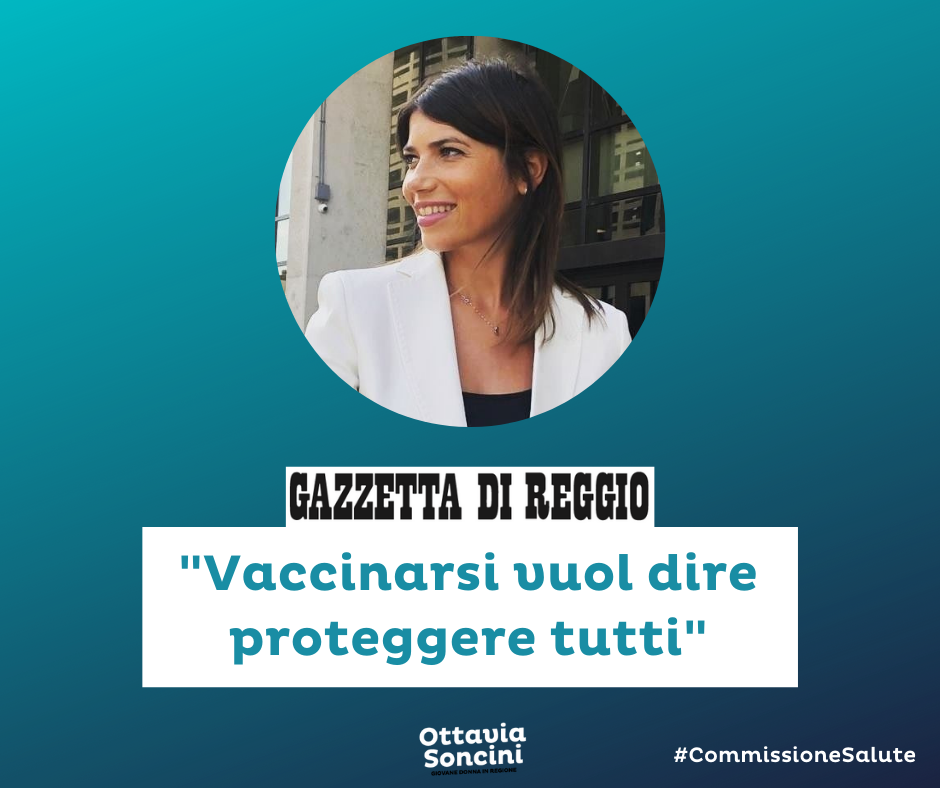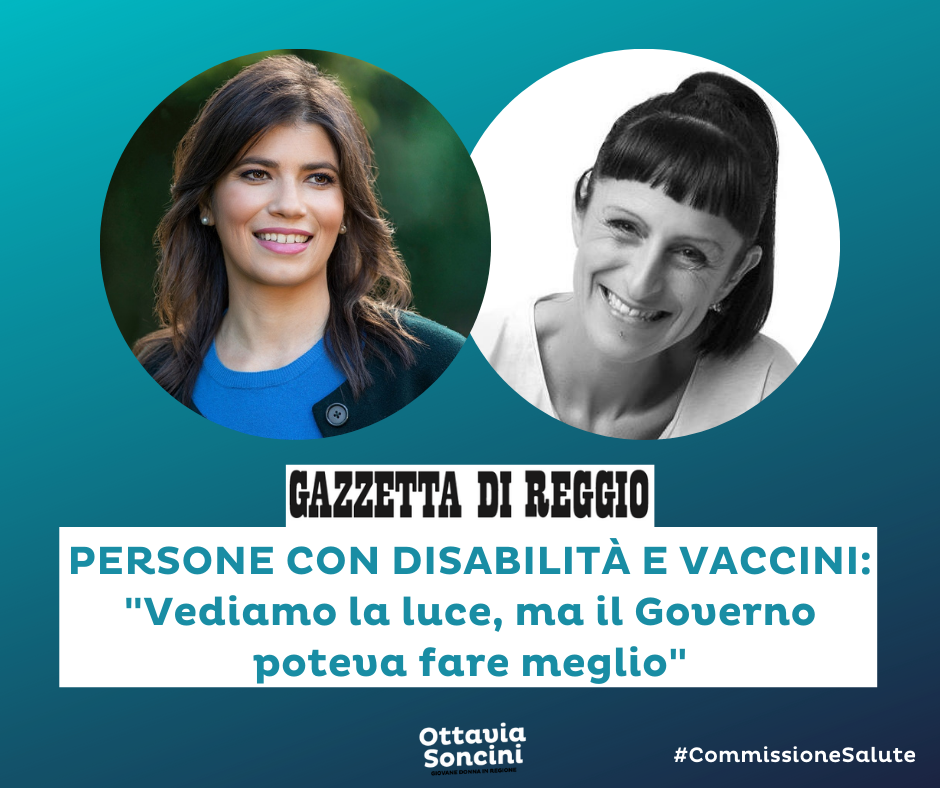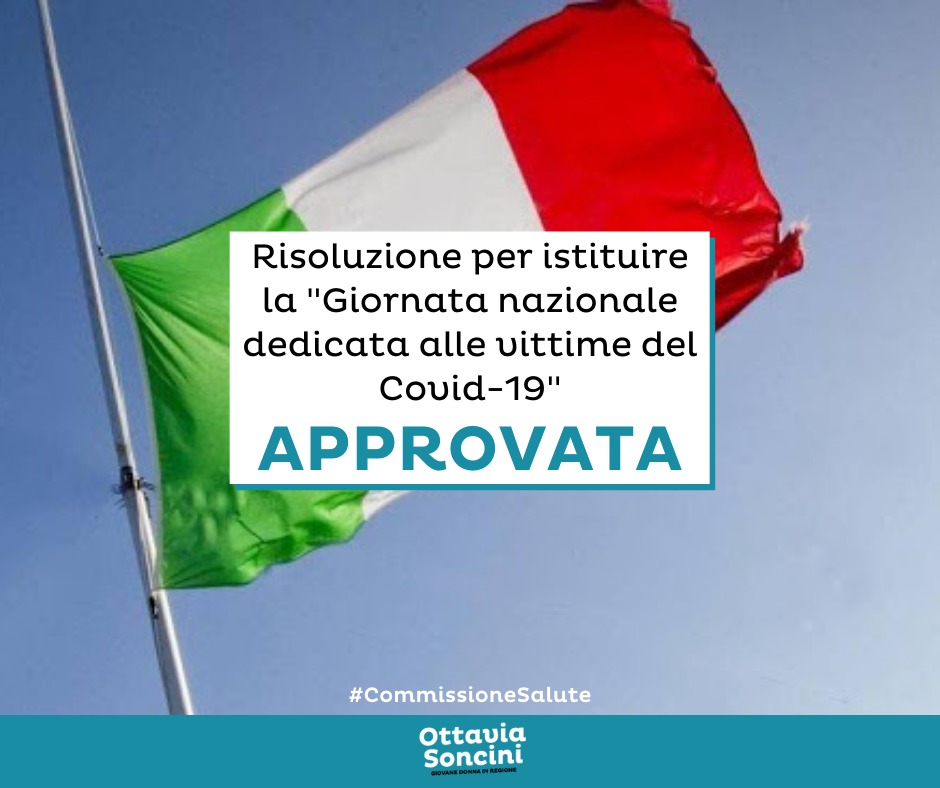Caro Matteo Salvini,
sono una consigliera regionale dell’Emilia-Romagna rieletta in questa legislatura e che ha vissuto in prima persona la campagna elettorale che hai condotto qui da noi nel gennaio 2020, sostenuto dalla Bestia famelica di vittime, da Bibbiano all’incensurato del Pilastro a Bologna. Come reazione al clima aggressivo scatenato dalla martellante campagna social, scelsi di caratterizzare la mia candidatura all’insegna della democrazia gentile, per prendere le distanze da un linguaggio violento, che diffondeva odio, razzismo e divisioni. Sono di cultura convintamente garantista e Luca #Morisi per me è innocente fino a prova contraria e delle sue vicende personali tu non porti alcuna responsabilità, tuttavia ti invito a una riflessione prendendo a pretesto la triste vicenda di questi giorni. La Bestia su tuo mandato o con la tua condivisone ha quotidianamente bersagliato persone, colpendole nel loro impegno, nel loro lavoro, nelle loro scelte, nelle loro fragilità. Ricordo bene la gogna riservata a Elsa Fornero, a Laura Boldrini, a Stefano Cucchi, a Giulia Viola Pacilli e a tanti altri, che spesso avete condannato sostituendovi a pubblici ministeri e a giudici. Gli immigrati, i musulmani, le donne, gli attivisti, gli outsider, i politici – gli altri ovviamente – come trovata per aizzare i cittadini (o forse i followers) al richiamo di una presunta identità nazionale, basata su Dio Patria Famiglia e sul Crocefisso esibito in modo del tutto inopportuno alle tribune elettorali. La messa alla berlina delle persone, le fake news, le distorsioni per finire in trend topic a tutti i costi e per determinare la diabolica relazione tra l’infrastruttura social, le televisioni, i giornali, le piazze e i bar nella diffusione del verbo leghista/salviniano/morisicano, col fine di avvelenare il confronto pubblico, a dire il vero rimettendosi nel solco ben arato dalla Casaleggio Associati. In quest’ottica la comunicazione diventa una mera tecnica di sollecitazione di onde emotive divisive, sostituendo il progetto politico, i temi comunicativi diventano temi politici, con l’evidente risultato di rimanere vittima degli stessi meccanismi promossi: dalla citofonata alla mano allungata per aiutare l’amico a rialzarsi, il cortocircuito è totale. Vedi Matteo, un politico non può scegliere quali fragili aiutare, la pietas deve essere massimamente democratica e deve valere per tutti, un politico non può essere credibile se sulle stesse pagine social trovi: ‘Cucchi se l’è cercata’ e ‘Morisi è un amico’. Funziona sui social dividere il mondo tra buoni e cattivi, non nella realtà. È indubbio che con le tue scelte hai inquinato la politica italiana, scelte comunicative disinvolte, ciniche e spregiudicate di cui porti la responsabilità più alta, addirittura negli anni di Governo la Bestia era l’ufficio stampa del Ministero degli Interni e pagata anche dai soldi dei cittadini. Insomma, tra te e la Bestia c’è completa sovrapposizione, la propaganda terrificante e pericolosissima di questo giro di anni ha la tua firma, la mostrificazione di Bibbiano, dei suoi amministratori, dei servizi, ha il tuo nome e il tuo cognome. Ora che sia proprio tu a lamentarti della gogna mediatica è un contrappasso che potrebbe anche essere divertente, qualora di mezzo non ci fosse la sofferenza esistenziale di una persona, di un essere umano che merita rispetto. Caro Matteo, cogli l’occasione, fai capire agli italiani che hai imparato la lezione: chiudi la Bestia. Prima del processo a Morisi, facciamo il processo alla Bestia ed allontaniamo gli aggressori verbali, l’orizzonte politico è profondamente cambiato: in questi due anni di pandemia hai avuto posizioni politiche che hanno fatto male al Paese, prima hai messo in dubbio l’utilità del distanziamento, poi quello delle mascherine, sei passato a lisciare il pelo ai no vax da vaccinato, infine hai pasticciato sul Green Pass diffondendo confusione e insicurezze, sempre inseguendo il trend topic del giorno, ma sei un leader politico non un influencer che guadagna con le interazioni. Chiudendo la Bestia daresti un segnale, aiuteresti anche il governo impegnato in uno sforzo titanico di cambiamento e innovazione del Paese e che fatica a confrontarsi con un partito sospeso tra la Bestia e Giorgetti, aiuteresti a ripristinare un clima di distensione e, alla fine, agevoleresti la democrazia gentile, di cui i nostri concittadini sentono un gran bisogno, perché il problema non è mai la bestia, ma il suo padrone.
Ottavia Soncini – Presidente Commissione Politiche per la salute e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna
*Lettera pubblicata sulla Gazzetta di Reggio l’1 ottobre 2021